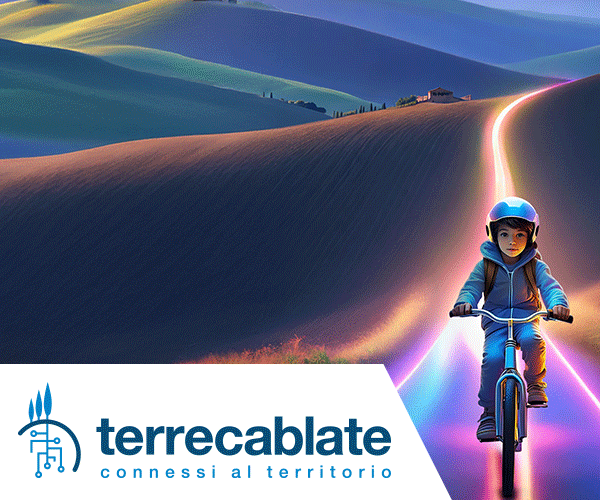Gianni Cuperlo, dal suo profilo facebook, il 2 luglio 2024
Sarà un esperimento per me, e per voi.
La premessa è questa: sarà un post lungo, molto lungo, di quelli che si ritengono incompatibili con questo mezzo.
Però, vorrei riflettere assieme a voi (chi ne ha voglia, ovviamente) sulla tragedia che da quasi dieci mesi insanguina una terra non distante da dove viviamo.
Farei così: lascerò il post per alcuni giorni in modo da dare il tempo (sempre per chi voglia farlo) di scorrerlo anche a pezzi, ma non avrei saputo dire qualcosa di sensato (o insensato, per altri) in una manciata di righe.
Ho deciso di farlo dopo mesi in cui, come tutti, mi sono interrogato sulle radici e matrici di quella tragedia (oltre naturalmente la condanna dell’eccidio di Hamas e della strage di civili palestinesi voluta da Netanyahu e dal suo governo).
L’ho fatto col turbamento di assistere a una sorta di conflitto tra posizioni rigide e indisponibili a scavare nel tempo e nella storia.
Bisognava arruolarsi da una parte o dall’altra, il che era e resta umanamente comprensibile se pensi a chi ha vissuto e vive su di sé il dramma di vite sottratte e un dolore lancinante che strappa la carne.
Ho deciso di scrivere questo post dopo alcune letture che mi hanno scortato in questi mesi: alcune più recenti (l’ultimo saggio di Gad Lerner, “Gaza. Odio e amore per Israele”, Feltrinelli, e il saggio del mio giovane amico e “maestro”, Gabriele Segre, “La cultura della convivenza. Di cosa parliamo quando parliamo di politica”, Bollati Boringhieri), altre più remote (una su tutte: “Esodo e Rivoluzione” di Michael Walzer, Feltrinelli).
So che su un tema tanto lacerante, complicato e doloroso, non posso chiedervi nessuna “regola d’ingaggio” o stile dei commenti.
Dunque, scrivete come sempre quel che volete: solo mi piacerebbe che ciascuno di noi (ragionando di pace, guerra, morte, sofferenza, tortura, torti e ragioni) provasse, almeno provasse, ad avvicinarsi al capitolo col pudore e l’umiltà di non dover spiegare a chi soffre sul campo come si deve vivere o come tocca morire.
Ecco, la premessa è stata già lunga di suo, mi scuso.
Adesso, cominciamo e grazie a chi arriverà in fondo…

Come detto, vorrei provare a riflettere con voi sulla tragedia che, solo negli ultimi nove mesi, poco più, ha visto morire 1.200 ebrei israeliani e oltre 37.000 civili palestinesi.
Non credo serva ripetere che quel conflitto non è iniziato il 7 ottobre di un anno fa, ma dura da decenni, almeno da quando le Nazioni Unite hanno sancito il diritto dello Stato di Israele a esistere unitamente al medesimo diritto da garantire a uno Stato palestinese.
Israele nasce nel 1948 mentre la reazione palestinese e del mondo arabo è contraria a quella disposizione e ne deriva la Naqba, l’esilio forzato di 700.000 palestinesi.
Nel 1967 con la Guerra dei sei giorni, Israele occupa territori che non sono di sua pertinenza e quell’occupazione si trascina per decenni fino a noi.
Dunque, il conflitto israelo-palestinese affonda in un tempo storico drammaticamente lungo.
Ora, anche grazie alla testimonianza di Gad Lerner, nel suo saggio ultimo, proviamo a risalire il sentiero.
Il pogrom di Hamas, il 7 ottobre, ha prodotto un numero di vittime civili che Israele non aveva mai contato nell’arco della sua storia: 1.200 morti, 240 sequestrati (il più piccolo aveva 10 mesi).
Il governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu non ha solamente sottovalutato la capacità militare di Hamas, ma ha lavorato al suo rafforzamento pensando che quella complicità avrebbe favorito la radicalizzazione dello scontro e l’annessione di fatto della Cisgiordania.
Come noto, Netanyahu è alla testa di un governo che comprende i partiti estremisti e religiosi (quelli che teorizzano da sempre l’espulsione della popolazione palestinese dalla sua terra nel nome di un dominio che non tollera la presenza di uno stato altro da Israele).
Da subito, il 7 ottobre, anche dentro Israele si sono levate voci che, nella condanna più assoluta dell’azione di Hamas, hanno individuato la responsabilità di quanto accaduto nella persona di Netanyahu.
Lo hanno accusano (in particolare lo ha fatto il quotidiano progressista Haaretz) di aver dato vita a un “governo di annessione e di esproprio”, praticando una politica che calpestava l’esistenza e i diritti dei palestinesi.
L’accusa era senza appello: si è voluta annettere la Cisgiordania anche attraverso quella che a tutti gli effetti si è rivelata una “pulizia etnica” in parte del territorio definito dagli accordi di Oslo.
Negli anni immediatamente precedenti Netanyahu, dopo il suo tentativo di riformare la Corte suprema asservendola agli interessi suoi personali e del governo, era stato oggetto di una contestazione clamorosa da parte di centinaia di migliaia di cittadini israeliani.
Detto ciò, la realtà nell’Israele di oggi è nel prevalere della linea più estrema, quella “del cosiddetto sionismo revisionista di Vladimir Zeev Jabotinsky, che, in polemica con David Ben Gurion, perseguiva la nascita di uno Stato esclusivamente ebraico, ragione per cui avrebbe dovuto erigere un muro di ferro tra sé e i suoi vicini”.
La reazione del governo israeliano è quella che abbiamo sotto gli occhi da mesi: l’obiettivo impossibile da raggiungere (la distruzione di Hamas) ha determinato l’uccisione di oltre 37.000 palestinesi, con un numero angosciante di bambini e donne.
La crudeltà dell’attacco del 7 ottobre non ha impedito ad Hamas di conseguire un consenso anche fuori dal campo islamico, reazione molto diversa rispetto agli attentati dell’11 settembre 2001 che a New York e Washington avevano provocato 3.000 morti.
Il sultano turco Erdogan, presidente della Turchia, paese aderente alla Nato, ha parlato di quei sicari definendoli “partigiani”.
Si è ripetuto spesso in questi mesi che Hamas non rappresenta i palestinesi, forse bisogna essere più espliciti: Hamas, cito ancora Gad Lerner, rappresenta “una serpe in seno, nata e cresciuta fra i palestinesi”.
Dalla sua nascita Hamas vincola la riscossa palestinese a un progetto religioso: santifica la lotta armata come strumento di espansione dell’Islam su scala mondiale.
“Per giustificare le sofferenze che impone alla sua gente teorizza la scelta del martirio proposta ai giovani come destino esaltante”.
In Hamas non c’è distinzione tra il vertice politico e l’autorità religiosa: le stesse stragi di civili palestinesi con il bagno di sangue vengono descritte come una pagina epica e provvidenziale, una “catarsi necessaria, la purificazione che renderà i palestinesi degni di ricevere, quando Dio vorrà, la ricompensa che spetta ai devoti”.
Questa follia cresciuta tra i palestinesi è, però, al tempo stesso “una creatura allevata e irrobustita della destra israeliana: il nemico perfetto nel quale rispecchiarsi, con il quale trattare anche se a parole se ne mette in dubbio persino l’appartenenza alla razza umana”.
Ciò che unisce Hamas e la destra israeliana è l’idea che si debba contrastare ogni possibile compromesso, la negazione assoluta dell’altro come nazione pareva avvantaggiare entrambi.
Ora, facendo un passo indietro, i leader dell’Olp erano in maggioranza cristiani, comunque laici, il che spiega il loro legame con il terzomondismo e il comunismo internazionale: questa era la situazione nel 1987 quando esplode in Cisgiordania, Gerusalemme e a Gaza la prima Intifada, o Intifada delle pietre.
Arafat era in esilio a Tunisi e i vertici dell’Olp non avevano pianificato né controllato la situazione, ma a stento nell’Intifada si individuava la presenza di una componente islamista (però fu proprio nel 1987 che dall’interno dei Fratelli Musulmani vide la luce Hamas, letteralmente: “movimento di resistenza islamico”).
In quegli anni, come giovani comunisti italiani, lanciammo una vasta campagna di solidarietà con la protesta dei giovani palestinesi (“Con la Palestina nel cuore” si chiamava).
Tenemmo centinaia di incontri, assemblee, manifestazioni, presidi, sempre animati dalla formula “Due popoli, due Stati”.
Lo ricordo per sottolineare quale incredibile e colpevole rimozione abbia caratterizzato, invece, gli anni più prossimi a noi dove il conflitto israelo-palestinese è progressivamente scomparso dalla nostra agenda, almeno fino al terribile risveglio, la mattina del 7 ottobre di un anno fa.
Ma torniamo alla prima Intifada e al 1987.
Rapidamente la nuova forza ottenne il sostegno di vari regimi arabi influenzati sia dai Fratelli Musulmani che dall’Iran (come descritto da Paola Caridi nel suo bellissimo saggio su Hamas quel movimento segna un passaggio fondamentale della vicenda mediorientale).
La carta fondativa di Hamas pubblicata nel 1988 dichiarava l’obiettivo di distruggere l’entità sionista nel nome del jihad, la guerra santa.
L’Intifada esplode perché i palestinesi erano stati spinti alla disperazione dalla politica di occupazione israeliana, una forma di umiliazione senza nessuna compensazione, neppure economica, e con una crisi di leadership dei loro dirigenti storici.
Quella prima protesta durò all’incirca cinque anni e alla fine si contarono più di 1.000 morti, prezzo all’epoca considerato troppo elevato da entrambe le parti.
Ma quella protesta accentuò anche la spaccatura del movimento sionista.
La rivolta palestinese metteva la classe dirigente di Israele di fronte a un’alternativa secca: cercare la via di un possibile accordo o proseguire all’infinito un conflitto senza sbocco.
I laburisti guidati dall’ex generale, Yitzhak Rabin, trassero l’idea che fosse necessario avviare un negoziato con l’Olp fino ad allora considerato un’organizzazione terroristica, mentre la destra del Likud, già guidata da Netanyahu, si opponeva a quella linea.
Si arrivò così alla trattativa di Oslo e al compromesso che prevedeva un calendario di graduale autodeterminazione dei palestinesi: l’accordo di pace venne firmato sul prato della Casa Bianca il 13 settembre 1993 con la storica fotografia della stretta di mano tra Rabin e Arafat mentre il presidente Clinton pareva quasi abbracciarli (cito ancora l’immagine utilizzata da Gad).
Quella pace è durata poco e ha attirato sui suoi artefici l’accusa di tradimento lanciata dalle componenti estremiste di entrambe le parti, da Benjamin Netanyahu e dai vertici di Hamas.
Due anni dopo, il primo ministro Rabin viene assassinato a Tel Aviv da un ebreo osservante convinto di adempiere alla volontà di Dio.
Netanyahu diventa Primo Ministro di Israele per la prima volta nel 1996: nega l’esistenza stessa di un popolo palestinese in quanto farebbe parte del più vasto mondo arabo e dunque potrebbe andare a cercarsi altri luoghi dove stabilirsi.
Hamas risponde con la stessa logica: è Israele che non ha il diritto di esistere poiché Gerusalemme è al tempo stesso capitale della nazione palestinese e luogo santo per tutta la umma islamica (insomma, non c’è posto tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo per uno Stato ebraico, a prescindere da quali ne siano i confini).
Hamas raccoglie gli appoggi dell’Iran, del Qatar, della Turchia, dell’Algeria, della Siria, fino alla Russia.
Il 7 ottobre conosce queste lunghe premesse: quel giorno i terroristi palestinesi uccidono 1.200 ebrei, solamente perché ebrei, le donne vengono stuprate, gli uomini torturati e mutilati.
Di lì a breve inizia la reazione terribile di Israele: le vittime civili palestinesi crescono di numero giorno dopo giorno: la cronaca registra omicidi di massa su una popolazione stremata, tutto giustificato dal governo d’Israele come il prezzo necessario per estirpare i vertici e i miliziani di Hamas.
Nessuna operazione chirurgica (come ad esempio avvenne dopo l’attentato di Monaco).
La rappresaglia, o vendetta, è brutale e non risparmia donne, minori, bambini.
Parlano le immagini, le testimonianze visive, le urla strazianti (esattamente come nella mattina del pogrom del 7 ottobre) e con dimensioni numericamente molto maggiori.
Tutto questo conduce in un pugno di settimane a un ribaltamento del giudizio dell’opinione pubblica mondiale (o comunque di una sua componente significativa).
L’immediata vicinanza e solidarietà verso Israele successiva al 7 ottobre si rovescia in una condanna ferma della reazione imposta da Netanyahu.
A nulla valgono le richieste pressanti dell’amministrazione americana a non riprodurre gli errori compiuti da Washington dopo l’11 settembre del 2001 e l’attentato alle Twin Towers.
Per Netanyahu quella risposta è al tempo stesso una macabra assicurazione sul proprio avvenire politico (e non solo) oltre che il solo modo per tenere agganciati a sé i partiti religiosi ed estremisti che ha imbarcato nella sua maggioranza.
Ma cosa implica oggi l’isolamento di Israele?
È un isolamento politico che ha raggiunto un livello mai toccato dopo la nascita dello stato di Israele.
Ma è anche un isolamento fisico: le frontiere con Libano e Siria sono chiuse da tempo per stato di guerra, quelle con la Giordania e l’Egitto sono riaperte, ma non sono certamente delle frontiere sicure.
Non bisogna mai dimenticarsi che Israele è un paese piccolo, sono 22.000 km², meno della Lombardia.
Con un ultimo aspetto che va rammentato: di fronte alle grandissime proteste contro il suo governo e la riforma della giustizia, nella primavera del 2023 (quindi prima del 7 ottobre) Netanyahu ha puntato a rompere l’isolamento nel quale si trovava facendosi modello di una destra europea dal profilo simile al suo.
Le proteste del sabato sera nella piazza di Tel Aviv avevano coinvolto centinaia di migliaia di cittadini per oltre 40 settimane di seguito, a quel punto il governo era davvero in bilico e paradossalmente è stato proprio il massacro del 7 ottobre a restituirgli la forza che non aveva più da tempo.
Ma arriviamo a una domanda fondamentale: si può essere nemici di Israele?
La risposta è No, si può essere critici e avversari del governo israeliano, ma con la capacità di distinguere.
Mi viene ancora una volta in soccorso la riflessione di Gad.
L’ebraismo racchiude una preziosa dimensione universalistica, il progetto nazionale del sionismo, e cioè l’ispirazione messianica, ma al tempo stesso terrena, ebraica e democratica, rischia però di venire snaturato dalla involuzione in atto nella società israeliana.
Tel Aviv si trova a 92 km dalla striscia di Gaza, la distanza che separa Trieste da Udine.
Israele tiene chiusa la frontiera di Gaza dal 2007, dopo che Hamas aveva vinto le elezioni ed esautorato con la forza la polizia dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Tradotto: su 2.300.000 palestinesi di Gaza, perlopiù profughi dal 1948 in poi, almeno una generazione non ha mai avuto il permesso di uscire da quel territorio sigillato.
Le condizioni di vita del cittadino israeliano medio rispetto a quelle di un palestinese di Gaza sono profondamente diverse: nel 2022 il reddito pro capite del primo era di 55.000 dollari l’anno, di 1.300 dollari quello del secondo.
Torniamo adesso alla cronaca di questi mesi: nel corso dell’operazione “spade di ferro” Israele si è macchiato di crimini di guerra (blocco dei rifornimenti di acqua, cibo e carburante, bombardamenti aerei, l’attacco agli ospedali, la demolizione di un terzo delle case, ha sparato sui fuggiaschi in marcia dopo che era stato loro ordinato di evacuare le abitazioni, massacato civili affamati che davano l’assalto ai pochi convogli umanitari autorizzati).
Critiche, ancora una volta è bene ricordarlo, presenti anche nella società israeliana.
Tamir Pardo, per cinque anni capo del Mossad, nominato da Netanyahu, ha animato la protesta con queste parole: “sono molti i cambiamenti che Netanyahu, attualmente sotto processo per corruzione, vorrebbe introdurre. Vuole fare in modo che i suoi ministri controllino i media, nominare i suoi fedelissimi in postazioni chiave dell’esercito e dei servizi di sicurezza, introdurre leggi religiose e imporle a cittadini laici, privare i palestinesi dei diritti umani fondamentali ed espellerli verso gli Stati arabi. In sostanza vuole creare un regime più autoritario”.
E ancora, sempre Tamir Pardo: “nel governo ci sono partiti razzisti e fascisti, paragonandoli al Ku Klux Klan gli ho fatto un complimento”.
La conclusione appare inesorabile: “Israele potrà essere sicuro e sopravvivere a lungo solo se rimane ebreo e democratico. Se rimane ebreo, ma diventa teocratico, non sarà più democratico. Se smette di essere un paese democratico, non merita di esistere”.
Quel “non merita di esistere” non è accettabile, ma fa riflettere la fonte dalla quale la frase proviene.
La realtà è che Israele ha rimosso la questione palestinese, volutamente l’ha ignorata.
Di fronte all’attacco che ha subito si è reso conto che non è possibile eliminare fisicamente l’avversario.
In questo quadro c’è la disfatta della sinistra israeliana, disfatta culturale di cui l’estinzione parlamentare è solo una conseguenza.
Dopo i falliti tentativi dei negoziati di pace con i palestinesi è come se i partiti della sinistra avessero rinunciato a caratterizzarsi per l’obiettivo “Due popoli, due stati “.
Cito ancora: “Hanno accantonato quel traguardo, ma senza dirlo, considerandolo non realizzabile ed elettoralmente svantaggioso, solo che in questo modo hanno rinunciato a un orizzonte ideale trovando conveniente concentrarsi sulle politiche sociali: di fatto la sinistra ha ristretto il suo raggio d’azione fino a rattrappirsi.
Avere sacrificato la strategia in favore della tattica è stato un calcolo sbagliato accompagnato da un ciclo di crescita economica dove iniziava a manifestarsi il malcontento delle fasce di popolazione che restavano isolate.
Nell’area geografica che comprende Israele, Cisgiordania e Gaza, la popolazione è più che decuplicata in un solo secolo: moltiplicandosi in misura uguale fra arabi ed ebrei.
In un contesto demografico simile non si può nemmeno immaginare che basti la superiorità militare a garantire la sopravvivenza di uno Stato nazione del popolo ebraico”.
Aggiunta importante (e che riguarda noi, nel senso della rimozione colpevole che ho ricordato all’inizio): bisogna conoscere la svolta del 18 luglio 2018 quando su proposta del quinto governo Netanyahu il parlamento israeliano ha approvato una Legge fondamentale che veniva ad aggiungersi alle altre 11 già vigenti.
“Le Leggi fondamentali in Israele assolvono di fatto una funzione para costituzionale: per i religiosi l’unica vera costituzione di Israele non poteva essere che la Torah.
I laici, a loro volta, sono sempre stati favorevoli a fare concessioni significative alle autorità rabbiniche pur di non inimicarsele e salvaguardare il pluralismo.
Una costituzione, quindi, non c’è, ma la svolta del luglio 2018 è di quelle che modificano il profilo che una nazione vuole dare di sé stessa: hanno votato a favore della nuova Legge fondamentale 62 deputati, 55 i contrari, due gli astenuti.
Per la prima volta Israele viene formalmente definito “casa nazionale del popolo ebraico” tra le cui finalità compare “lo sviluppo degli insediamenti ebraici come valore nazionale”, uno “sviluppo degli insediamenti ebraici”, si badi bene, valorizzato senza alcuna delimitazione territoriale riguardo ai futuri confini dello Stato stesso, uno schiaffo ai palestinesi, compresi gli arabi israeliani”.
E non è l’unico schiaffo: nel seguito del testo viene stabilito che, correggendo la dichiarazione del 1948, l’arabo smette di essere affiancato all’ebraico come “lingua dello Stato, viene retrocesso, concedendogli solo uno “status speciale”.
Quel voto esprime la visione del mondo etnocentrica che riprende come cardine il sionismo revisionista della destra: quello già citato di Vladimir Jabotinsky opposto a quello di David Ben Gurion.
Il primo manifestava la sua ammirazione per il fascismo italiano di cui cercò di imitare il primo modello organizzativo paramilitare e squadrista, ma soprattutto era convinto che lo Stato ebraico non potesse sorgere che sulla base di una omogeneità nazionale dei suoi abitanti, condannava qualsiasi tentativo di convivenza con gli arabi dei quali bisognava separarsi edificando un “muro di ferro”.
Le due correnti rivali del sionismo si sono contrapposte per quasi un secolo, prima e dopo la nascita dello Stato, ma avevano in comune il profilo laico, secolare dei loro dirigenti.
“Nessuno cercava nella Bibbia legittimazione per le proprie aspirazioni nazionali, non erano ebrei osservanti e per questo venivano osteggiati dalle principali autorità del rabbinato secondo cui non si poteva forzare il Messia, e dunque il ritorno alla Terra Promessa si sarebbe potuto realizzare solo alla fine dei tempi, per esclusiva volontà del Signore”.
“Entrambi gli schieramenti, quello maggioritario di Ben Gurion e l’altro si rifacevano a un terzo pensatore laico, il viennese Theodor Herzl, e al suo testo fondativo del sionismo, “Lo Stato ebraico”, pubblicato nel 1896, che però non contiene nessun riferimento alla Bibbia né alla terra di Palestina.
Metteva in conto che all’occorrenza la patria degli ebrei potesse situarsi anche altrove.
Spiega Gad, “Chi leggesse quel libro troverebbe accenti che oggi suonerebbero antisemiti là dove egli sollecitava le nazioni europee a liberarsi del “fastidio” della presenza ebraica sui loro territori”.
Bene, a questo punto torniamo un istante alla radice storica: il 26 novembre 1947 la Società delle Nazioni votò a grande maggioranza il piano di partizione della Palestina: il rappresentante di parte ebraica lo accettò subito, pure mettendo agli atti che avrebbe comportato dolorose rinunce territoriali, mentre i sionisti revisionisti gridavano al tradimento, ma neanche loro motivavano il dissenso rifacendosi alla Bibbia.
Al contrario la rappresentanza arabo-palestinese rifiutò la spartizione proposta senza chiedere uno Stato per il suo popolo, ma sostenendo che l’intero Medio Oriente, fino all’oceano Indiano doveva considerarsi terra dell’Islam.
Il rifiuto arabo si trasformò in guerra: il nascente Stato ebraico durante quella che gli israeliani chiamano la guerra di indipendenza del 1947-1948 pianificò per via militare operazioni violente di pulizia etnica dentro e oltre i confini indicati dalla Società delle Nazioni: i profughi messi in fuga verso la Cisgiordania, Gaza e Libano furono centinaia di migliaia.
Era l’inizio del dramma palestinese.
Dopo il 1967 quasi tutti i governi israeliani hanno tollerato o favorito la politica degli insediamenti.
I coloni vivono fuori dai confini di Israele, ma sono considerati cittadini a pieno titolo: molti sono immigrati di recente dagli Stati Uniti e sembrano cultori della violenza piuttosto che della tradizione ebraica.
Più o meno è in questa cornice che si è sviluppata la stagione più recente: il 7 ottobre con un pogrom che ha sconvolto la popolazione israeliana e il mondo intero, e da lì la carneficina che ha consumato quasi ogni residua speranza di umanità in quella terra martoriata con decine di migliaia di morti innocenti.
Oggi è giusto insistere in ogni sede affinché la mattanza di Gaza abbia termine, perché vengano liberati tutti gli ostaggi e si riconoscano pienamente i diritti del popolo palestinese nella assoluta garanzia sulla sicurezza di Israele.
Resta, enorme, il capitolo del dopo.
Da più parte si sente ripetere che la prospettiva dei “Due popoli, due Stati” andrebbe definitivamente abbandonata perché irrealizzabile.
Anche se cosi fosse (e sarebbe comunque un dramma nel dramma), nulla può e deve impedire che altri processi di pacificazione trovino la luce.
In questo senso, sarà responsabilità e compito dei protagonisti (delle loro componenti più consapevoli che una convivenza dev’essere possibile) andare alla ricerca ostinata di una soluzione.
Nel negare questo spazio si concentra oggi il senso di un primato della geopolitica intesa come analisi razionale (non dico cinica) dei fattori in campo, dei rapporti di forza e di potenza fermandosi a quelli.
Ma da sempre, anche a fronte dei conflitti più aspri e devastanti, l’azione politica, quella animata da una visione illuminata e a modo suo creativa, non si è mai ridotta unicamente ad analisi razionale.
Deve, per necessità, contenere dentro di sé una dose di ragionevole e moderata utopia.
Deve indagare, scavare, perorare, la causa più impossibile, il traguardo in apparenza più distante: perché solo così un conflitto senza sbocco può trovare il sentiero di una tregua e pacificazione.
La storia di episodi simili ne ha offerti molti, oggi questa sentiero ci sembra precluso e dobbiamo sperare che alla guida di quei due popoli (ed eserciti) vi siano all’orizzonte figure capaci per convinzione e prestigio di imboccare quella via.
Anche per questo, però, non credo basti “arruolarsi“ sull’una o l’altra frontiera.
Piangere i morti, tutti i morti, è la sola strada concessa per chi voglia avventurarsi nella trama di un conflitto che dura da oltre settant’anni e che troverà pace solamente quando lo Stato di Israele vedrà garantita la sua integrità e sicurezza, e il popolo palestinese sarà riconosciuto nella sua dignità entro i confini di uno Stato sovrano.
Noi, la sinistra, facciamo bene a batterci perché il diritto di quello Stato a nascere e ad essere riconosciuto trovi riconoscimento anche nel nostro paese.
Allo stesso tempo, dobbiamo chiedere scusa per la rimozione colpevole di una tragedia che non si è mai arrestata e sulla quale troppo a lungo è scesa una coltre di silenzio.
Ecco, questi sono alcuni dei pensieri che volevo condividere assieme a voi.
Quasi nessuno è originato da me, se non qualche commento sparso, ma forse su pochi altri argomenti siamo chiamati a riflettere soltanto dopo avere praticato lo sforzo di capire ragioni e torti di ciascuno.
Il che non vuol dire coltivare la reticenza, ma (come forse direbbe il mio amico Gabriele) significa allevare la convivenza in quella sorta di miracolo laico dove la Storia non si ferma mai.
Un abbraccio e grazie