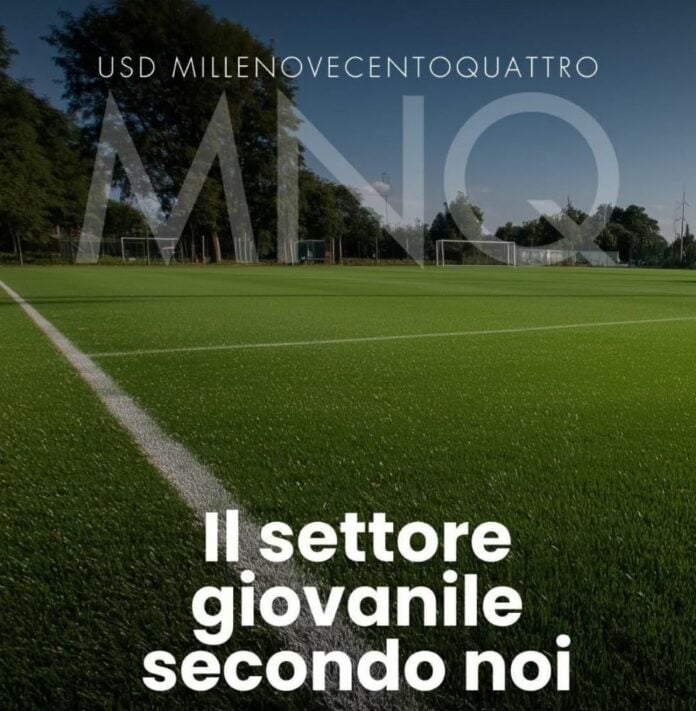All’iniziativa di Usd Millenovecentoquattro l’immagine di uno sport capace di educare senza addestrare, includere senza classificare, ascoltare senza semplificare
Ho assistito all’iniziativa “Il settore giovanile secondo noi” con la sensazione netta che qualcosa di autentico si stesse muovendo sotto la superficie consunta del dibattito sportivo. Niente frasi di circostanza, nessun ricatto retorico sull’importanza dei giovani.
A Palazzo Patrizi, dentro le pareti sobrie di un luogo antico, si è parlato con urgenza e lucidità di autonomia, conflitto e cooperazione. Tre parole che, in quelle ore, non sono rimaste appese nell’aria, ma si sono incarnate nelle esperienze raccontate, nei gesti, nei dubbi condivisi.

Autonomia, innanzitutto. L’autonomia dei ragazzi, che va riconosciuta, non concessa. I tecnici presenti — da USD Millenovecentoquattro e non solo — hanno raccontato quanto sia difficile oggi garantire spazi in cui i bambini possano giocare senza la pressione di dover diventare qualcuno, senza lo sguardo incessante dell’adulto che corregge, indirizza, giudica. L’autonomia è anche quella delle famiglie, che devono potersi fidare delle società sportive e non essere costrette a diventare “ultras educativi” per proteggere i propri figli. E, in fondo, è anche l’autonomia delle stesse società dilettantistiche, spesso schiacciate tra burocrazia e abbandono istituzionale.

Ma tutto questo non si conquista senza passare per il conflitto. È emerso con chiarezza che crescere — nello sport come nella vita — significa attraversare contraddizioni. Gli errori, le sconfitte, le frustrazioni non sono fallimenti da evitare, ma occasioni per imparare. Un ragazzo che non sperimenta mai il conflitto — con sé stesso, con i compagni, con l’autorità dell’allenatore — rischia di restare in una bolla irreale, fragile. E invece il campo, se guidato da adulti consapevoli, può diventare uno dei pochi luoghi rimasti in cui si può sbagliare senza essere giudicati, si può reagire senza essere stigmatizzati.

Infine, cooperazione. Forse la parola più potente di tutte. La cooperazione tra le società sportive, spesso chiuse nei propri confini identitari. Quella tra tecnici e famiglie, tra scuola e sport, tra enti pubblici e realtà associative. Tra supporter. Ma anche la cooperazione come valore da trasmettere ai giovani: passare la palla, ascoltare un compagno, gioire insieme, farsi da parte. In un mondo che celebra l’individuo e isola i fragili, la cooperazione è una pratica rivoluzionaria.

Questo è stato, per me, il senso dell’iniziativa. Un momento non autoreferenziale ma collettivo, dove si è tornati a dire che lo sport giovanile non è un parcheggio né un trampolino di lancio, ma un luogo dove si impara a stare al mondo. Con gli altri, mai contro gli altri. E dove l’educazione non è delega, ma scelta quotidiana. Faticosa, certo. Ma necessaria.