La morte di Andreas Tonelli va compresa non semplificata
Quando il corpo di Andreas Tonelli (foto, fb pubblica) è stato recuperato, 200 metri più in basso, sotto un canalone verticale in Val Gardena, si è chiuso un altro cerchio tragico nel mondo degli sport estremi.
Ma se vogliamo davvero capire, non possiamo fermarci alla cronaca. Perché Tonelli non era uno sprovveduto, né un incosciente in cerca di visibilità. Era un uomo che aveva fatto della montagna una forma di vita e di relazione con sé stesso. E proprio qui si apre la domanda centrale: cosa spinge certe persone, oggi più che mai, a cercare deliberatamente il limite, anche quando questo si affaccia sul nulla?
Il fenomeno non è nuovo. Era già nei pionieri del paracadutismo, nei primi che sperimentavano il deltaplano in condizioni precarie, negli scalatori solitari che affrontavano pareti verticali senza corde. Oggi questa spinta ha preso una molteplicità di forme: alpinismo estremo, mountain bike verticale, tuta alare, free solo, parkour urbano, highline, parapendio acrobatico. Non si tratta di “sport” nel senso consueto, ma di una vera e propria estetica dell’esistenza al margine.
Molti etichettano questi individui come “sensation seekers”. Ma chi ha davvero visto da vicino queste pratiche sa che la realtà è più profonda e meno riducibile a un’etichetta psicologica. Per alcuni, il rischio è una forma radicale di attenzione. Per altri, un modo per zittire il rumore del mondo. In un’epoca in cui tutto è previsto, assicurato, razionalizzato, il rischio estremo diventa l’unico spazio dove l’imprevisto è ancora autentico. È lì che si sente, nel senso più pieno del termine, la vita.
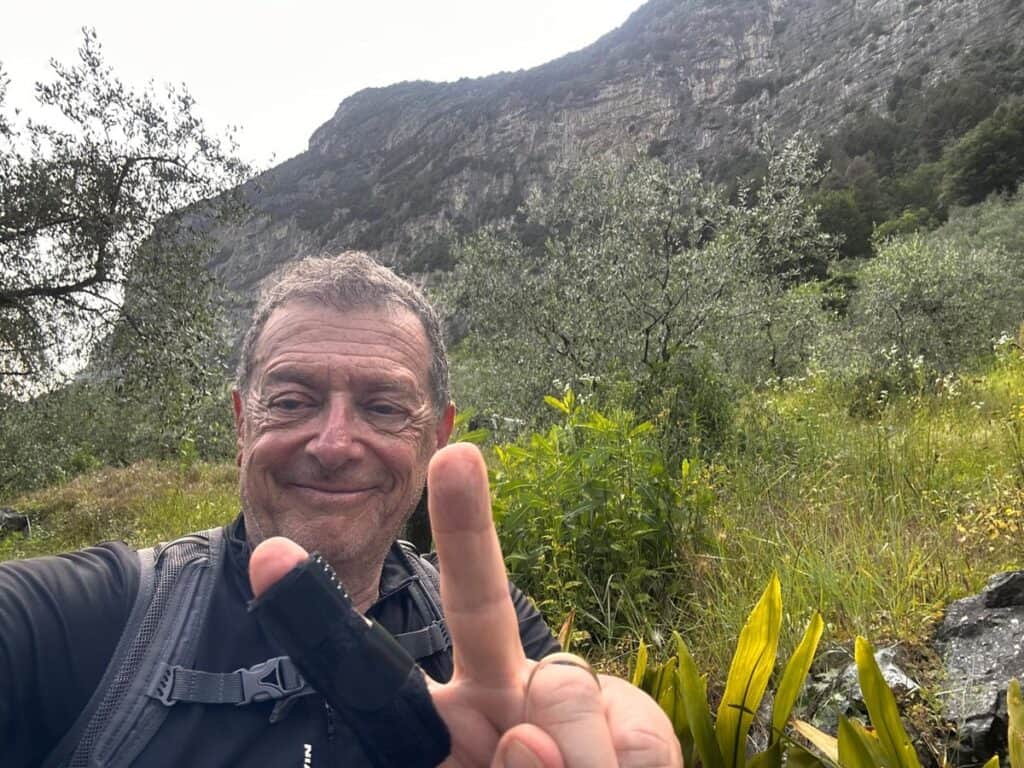
Ma oltre alle narrazioni personali e culturali, c’è qualcosa di più radicale ancora: il corpo. Il sistema nervoso. La biochimica. Le neuroscienze sanno ormai con buona certezza che in questi soggetti l’equilibrio tra dopamina, noradrenalina e serotonina – i principali neuromodulatori coinvolti nell’arousal, nell’attenzione, nella motivazione e nella regolazione emotiva – ha caratteristiche peculiari.
Nello specifico, chi ricerca l’estremo mostra spesso una maggiore densità e sensibilità dei recettori dopaminergici D4, associati alla tendenza a cercare stimoli nuovi, intensi, ambigui. È come se il loro sistema dopaminergico avesse una soglia diversa: solo esperienze altamente imprevedibili e rischiose producono una risposta di gratificazione e motivazione comparabile a ciò che per altri basta una sfida normale, una novità consueta. Questo può generare un circuito ricorsivo, dove il comportamento rischioso non è più solo una scelta, ma un bisogno, quasi un adattamento.
Al contempo, il sistema noradrenergico, che regola l’attivazione e la vigilanza, è spesso più reattivo e meglio integrato con il controllo motorio e visivo: non si tratta quindi di incoscienza, ma di una percezione alterata – più fluida e meno ansiogena – del pericolo. Questi soggetti percepiscono il rischio in modo diverso, non necessariamente sottovalutandolo, ma metabolizzandolo come componente naturale dell’esperienza, non come allarme.
E infine c’è l’asse serotoninergico, che nei profili ad alto rischio mostra tendenze variabili: in alcuni, una regolazione emotiva più fragile può sfociare in una ricerca compulsiva del superamento del limite come forma di autoregolazione; in altri, la stabilità emotiva permette invece un controllo straordinario anche in situazioni estreme.

È per questo che non possiamo parlare solo di passione o coraggio. In questi comportamenti c’è una struttura neurochimica di fondo che orienta la scelta, che modula la percezione del rischio, che determina l’intensità dello stimolo necessario a produrre senso di sé. In altre parole, il gesto estremo non è solo una volontà, è anche un destino biologico.
Non tutti sono fatti per stare sospesi su una fune a cento metri da terra. Ma chi lo fa, spesso, non potrebbe fare altrimenti.
E se posso aggiungere qualcosa, io li comprendo perfettamente. Non solo come psicologo o studioso, ma da dentro. In forme diverse, forse più regolate, ho vissuto esperienze dove il margine era sottile, e la posta in gioco molto alta. Scelte di vita, di libertà, di esposizione. E so che non si tratta di “cercare il pericolo”, ma di rifiutare una vita in cui tutto sia previsto, mediato, sterilizzato.
Quelli che scelgono il vuoto, la quota, la fatica, il gelo, non vogliono morire. Vogliono essere vivi. E per questo, anche quando cadono, ci parlano più degli altri di cosa significhi esistere con tutto il corpo e tutta la mente.



