Esperienze sul campo e riflessioni sul fenomeno migratori. Ne parliamo con il governatore Roberto Fé
La Misericordia di Chiusi si occupa direttamente di accoglienza e supporto ai migranti. Quali sono le principali attività che svolgete?
“La Misericordia si occupa da circa 15 anni di accoglienza secondaria e nel tempo le attività si sono evolute secondo le necessità dell’utenza e le direttive del governo. Senza dubbio, quando abbiamo iniziato ad occuparci di migranti, nel panorama italiano si trattava di una novità e l’approccio all’accoglienza con modalità strutturate rappresentava l’alba di un’era carica di speranza. Facendo un passo indietro, per spiegare anche a chi non si occupa di immigrazione ed accoglienza, il processo di richiesta di asilo politico di un cittadino straniero si articola due fasi; nella prima, quella di ingresso sul territorio italiano, il richiedente si sottopone all’identificazione da parte delle forze dell’ordine, formalizzando di fatto la richiesta di asilo politico. La seconda fase, cosiddetta accoglienza straordinaria, quella in cui noi accompagniamo gli ospiti, si sostanzia della garanzia da parte del Governo italiano di fornire mezzi di sostentamento all’utenza che da questo punto di vista ne è sprovvista, quindi vitto, alloggio e assistenza medica e legale, durante il periodo che intercorre tra la prima fase e l’audizione in commissione territoriale, la quale decreterà l’accoglimento o il diniego della richiesta di asilo del singolo ospite. Ecco, nella forbice temporale che intercorre tra l’ingresso in Italia ed il decreto della Commissione, in convenzione con la Prefettura di Siena, la Misericordia di occupa in primo luogo di offrire agli ospiti alloggio e sostentamento, nonché sostenerli nel percorso legale offrendo servizi di informativa e mediazione, oltre ad occuparsi nella quasi totalità delle necessità mediche degli ospiti. In secondo luogo, è parte integrante del nostro codice morale ma anche dello Statuto, promuovere l’integrazione comunitaria e sociale degli ospiti dei nostri centri, cercando di costruire con loro percorsi formativi e lavorativi che seguiamo anche dopo la cessazione dei benefici di accoglienza”.
Come è cambiata nel tempo la situazione dell’accoglienza nel territorio?
“È innegabile che nei 15 anni di esperienza sul campo, ci siano stati graduali ma importanti cambiamenti nella gestione dell’utenza migratoria, soprattutto a causa dell’aumento del flusso stesso e dei decreti che hanno determinato un’accelerazione del processo di accoglienza, togliendo tempo da dedicare al singolo caso e aumentando le risorse da impiegare. Tuttavia, finché saremo in grado, continueremo sempre ad occuparci di accoglienza”.
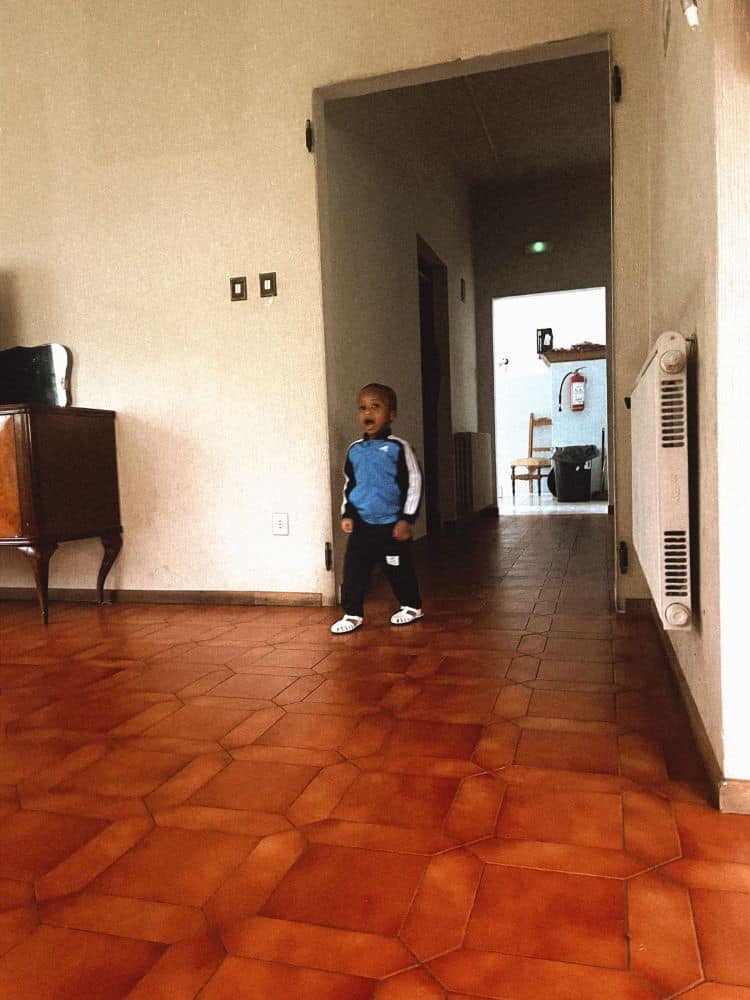
Il linguaggio ha un peso nella narrazione del fenomeno migratorio. Spesso si usano termini diversi: profughi, migranti, richiedenti asilo. Quanto è importante la distinzione tra queste categorie?
“Certamente, su scala globale, gli appellativi sono parte di un più vasto disegno di propaganda, utilizzato per veicolare l’opinione pubblica sulla base degli interessi politici di chi ne tratta. Al livello sociale il tema migratorio è ancora un argomento caldo, che purtroppo, anziché unire, divide le persone. Tuttavia, essendo la nostra Misericordia incastonata in una piccola realtà, viviamo quotidianamente e da vicino situazioni discriminatorie nei confronti degli ospiti e se abbiamo capito una cosa è che poco conta come legalmente un cittadino straniero è presente sul territorio italiano, chi è propenso al razzismo lo è a prescindere dalla natura della migrazione e chi non lo è aiuterà sempre il prossimo”.

Chi affronta viaggi pericolosi e lascia tutto alle spalle è spesso descritto come un disperato o un avventuriero. Ma le cause reali sono complesse: guerre, povertà, cambiamenti climatici, instabilità politica. Possiamo dire che questi “dannati della terra” siano vittime del caso o piuttosto il prodotto di un sistema globale malato?
“Le condizioni psicofisiche in cui vediamo arrivare molti dei nostri ragazzi sono talmente sconcertanti da non avere dubbi che, se hanno consapevolmente scelto di affrontare una “avventura” ai limiti della sopravvivenza, verso un futuro comunque incerto, la loro vita nel paese d’origine non poteva che essere insostenibile. Senza interrogarsi particolarmente sulle motivazioni che spingono i singoli ospiti al viaggio senza speranza, si può affermare con certezza che anche laddove non sussistano agli occhi dell’Europa condizioni di rischio acuto e riconosciuto per la vita della persona, in un modo o nell’altro la sicurezza è sempre a repentaglio. Basti pensare che non è necessaria una guerra riconosciuta al livello internazionale perché in un paese si muoia di fame o si sia vittime sistematiche di attacchi alla popolazione civile. Siamo fermamente convinti che non esista persona al mondo che sceglierebbe di abbandonare la propria terra, la propria famiglia, i propri usi in virtù della speranza di potersi (forse) integrare in un paese completamente diverso da quello di provenienza; al netto di queste considerazioni, niente è lasciato al caso e che i flussi migratori eccessivi, disorganizzati, illegali sono prodotti di un sistema globale fallato e incurante delle conseguenze sulla vita del singolo e delle società”.
Per molti i migranti rappresentano un problema, un elemento di conflitto sociale. Per altri sono un’occasione di lucro, tra business dell’accoglienza e sfruttamento lavorativo. Per pochi, invece, una risorsa e un’opportunità. Tu come la vedi?
“Nel belpaese, messo in ginocchio dalla crisi del lavoro, risulta utopico ragionare in termini di inclusione e poter considerare quindi l’immigrazione come un’opportunità e una risorsa, maggiormente perché la tendenza, diciamoci la verità, è quella di sfruttare il migrante e laddove non possibile, sicuramente non aiutarlo. Alla luce proprio di questa consapevolezza, la Misericordia ha fondato la Don Pipparelli, una Impresa Sociale a carattere agricolo, proprio per offrire opportunità di formazione e lavoro e contrastare nel nostro piccolo il caporalato dilagante. Al netto dei due anni di esperienza possiamo però dichiarare che, se presentati davanti alle giuste condizioni e sostenuti nel percorso, i migranti rappresentano non solo forza lavoro, ma anche arricchimento e valorizzazione del tessuto sociale. Per quanto riguarda invece il tema del lucro nell’ambito dell’accoglienza, ci tengo personalmente a precisare che la gestione delle Prefetture, almeno per quanto riguarda la Provincia di Siena, si è affinata ed evoluta negli anni ed attualmente attraverso i decreti trasparenza, il monitoraggio e la rendicontazione dettagliata, non lascia minimamente spazio ad alcuna manovra di lucro o sfruttamento. Sappiamo però che non è sempre stato così”.
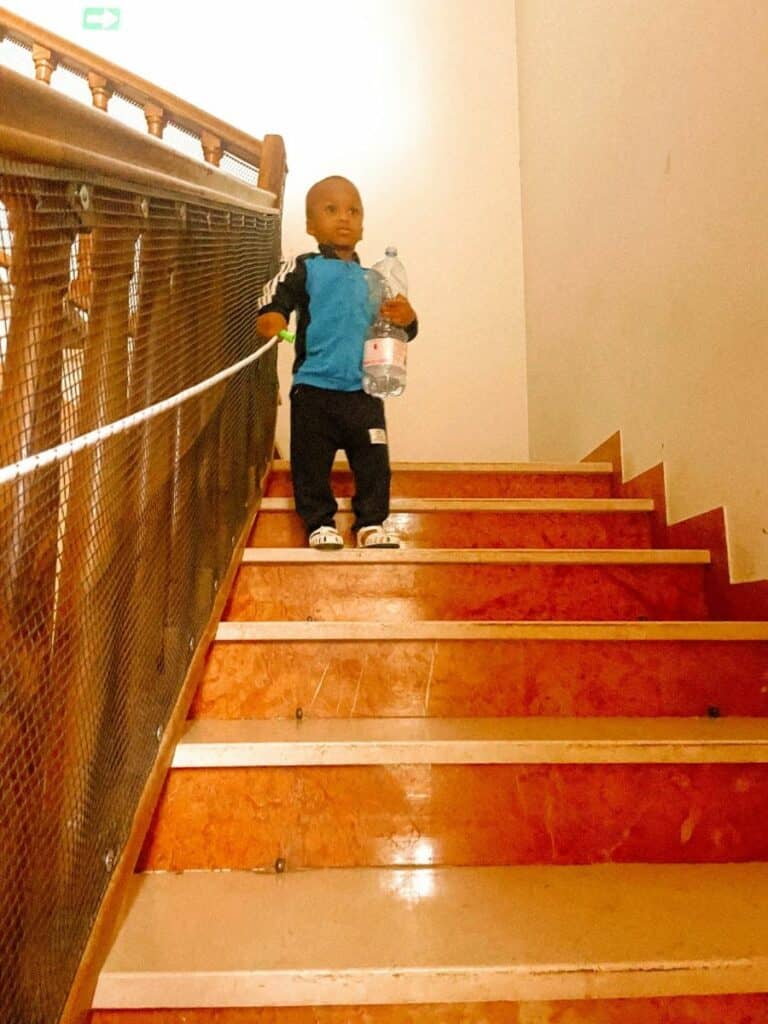
Una delle vie di ingresso per l’Europa passa anche dalla nostra provincia. Siena è solo una tappa di passaggio o sta diventando una meta per chi arriva? Ti sei fatto un’idea delle ragioni dietro questa dinamica?
“Siena è sempre stata una provincia attiva e disponibile per il sociale, non escludendo quindi anche l’accoglienza dei migranti. Penso di poter affermare che oramai si tratti di un sistema consolidato e che anche nella comunità migrante si sia sviluppata la consapevolezza che sul territorio senese esistano opportunità di formazione, lavoro, integrazione ed autonomia, rendendola quindi per molti una meta dove stabilizzarsi. Se dovessi individuare una motivazione dietro al fenomeno penserei che un pilastro potrebbe sicuramente essere ricercato nella grande disponibilità di lavoro nel mondo agricolo, che rappresenta opportunità più accessibili per una comunità tendenzialmente a bassa istruzione, come può essere quella migrante. Ecco, sicuramente si tratta di un complesso insieme di fattori, che spinge molti migranti a rimanere nelle nostre zone. Molti di loro dicono di essere attratti dalla “tranquillità” del quotidiano”.
Affrontare il fenomeno solo a valle, quando i migranti arrivano, è difficile e spesso inefficace. Cosa si potrebbe fare concretamente, a livello locale e nazionale, per gestire meglio la situazione?
“Non neghiamo che i flussi migratori e le modalità con cui ci troviamo a dover gestire l’utenza rappresentano spesso un carico eccessivo e non sempre ci permettono di porre l’attenzione necessaria al singolo, se non per quanto concerne i bisogni primari. Siamo consapevoli che il nostro paese non possiede le risorse necessarie per affrontare il numero di cittadini stranieri che quotidianamente fanno ingresso nel territorio, ma non crediamo che la soluzione vada ricercata nel respingimento degli stessi al momento dell’ingresso, quanto nella sistematizzazione e distribuzione dei cittadini in aree più vaste, comprendendo sicuramente più provincie sul territorio. In secondo luogo, ma non per ordine di importanza, a mio avviso sarebbe necessaria una politica europea più coesa e collaborativa, che prediliga l’affrontare il fenomeno migratorio, d’interesse globale, come una questione da disciplinare e da risolvere pragmaticamente”.

Le voci contrarie all’accoglienza sono spesso forti e chiare. Quelle favorevoli, invece, sembrano più deboli e frammentate. Inoltre, manca quasi completamente la voce diretta dei migranti. Come si può dare spazio a una narrazione più equilibrata e coinvolgere direttamente chi vive questa esperienza?
“Come detto prima, è difficile eradicare concetti politici veicolanti, se la propaganda mira a virare l’attenzione del popolo su categorie con cui è facile prendersela, perché hanno la pelle di un altro colore, parlano una lingua che non è italiano e sono disposti a fare lavori che noi non facciamo più. È proprio da questa tendenza a dipingere chi immigra come qualcuno di cui avere timore o risentimento che deriva poi il senso comune di intolleranza e ghettizzazione. Ho sempre pensato che chi parla molto è perché fa poco e viceversa, ragion per cui chi è impegnato nel sostenere categorie fragili si occupa effettivamente di quello e ha poco tempo per presenziare a combattere quella fetta di persone che invece si accanisce contro ingiustizie fantasma. L’ingiustizia non è rappresentata dalla comunità bengalese o maliana o ucraina presente sul nostro territorio, ma da un sistema che fallisce a monte nel sostenere i cittadini si qualsiasi provenienza o status. La chiave sta nel convincersi che la soluzione non sta in una guerra tra poveri, ma in una presa di coscienza collettiva che ci aiuti a lavorare insieme per un futuro migliore per i figli di tutti. Nel nostro caso ci teniamo particolarmente a diffondere informazioni, esperienze, conoscenze da parte dei ragazzi ed abbiamo constatato che il modo migliore per riuscirci è quello di coinvolgerli in eventi comunitari, associazioni, realtà che piano piano diano loro spazio e modo di esprimersi ed integrarsi”.

Chi parte per questi viaggi della speranza non fugge solo da qualcosa, ma cerca qualcosa: un futuro migliore. Spesso il viaggio rappresenta il più grande investimento che una famiglia possa fare, affidando al migrante la possibilità di costruire un domani per sé e per chi resta. È un aspetto poco raccontato. Qual è la tua esperienza su questo?
“Sono poche le persone che arrivano da noi con la sola preoccupazione di sopravvivere per se stessi. La maggior parte di loro ha in effetti un carico emotivo e morale molto pesante, fatto da speranze e paura di deludere chi è rimasto indietro, spesso anche eccessivo e talvolta ingiusto ai nostri occhi. Nonostante ciò, questa è la realtà e purtroppo, nella maggior parte dei casi nella loro percezione ci sono delle aspettative non compatibili con la realtà per ovvie ragioni – non si può pensare che un sistema regga il peso di mantenere migliaia di famiglie intere, anche se in paesi con costi della vita molto più bassi del nostro. Questa è una consapevolezza relativamente diffusa anche nella comunità migrante stessa, ma nonostante questo la meta europea rappresenta comunque una visione della vita migliore di quella presente nel paese d’origine. Anche sapendo che hanno la possibilità di non riuscire nell’intento, affrontano comunque il fatidico viaggio e s’impegnano lo stesso nel costruirsi una porzione di realtà, con grandi sacrifici”.
C’è una domanda che non ti è stata rivolta e a cui avresti voluto rispondere? Se sì, quale e cosa risponderesti?
“Vorrei condividere una riflessione personale. Lavorare con le categorie vulnerabili, di cui i migranti intrinsecamente fanno parte, è una condizione controversa, complessa e delicata, soprattutto nel contesto politico-economico globale in cui ci troviamo al momento. Chi, come noi, è in prima linea nell’accoglienza, spesso si trova sotto pressione, come tra due fuochi, dovendo costituire un ponte vero e proprio tra la società ed il migrante, in tutti gli aspetti della quotidianità. Il carico burocratico è disarmante, la difficoltà data dalle differenze culturali rende tutto più complesso e sicuramente non si toglie dall’equazione la diffidenza degli italiani e la mancanza di comprensione da parte dei migranti di “come funzionano le cose da noi”. Aggiungo che, come detto prima, anche volendo non c’è spazio di manovra per “fare un sacco di soldi coi profughi”. Alla luce di questo concluderei dicendo che avrei piacere se l’opinione pubblica considerasse e ponderasse queste diverse variabili, che concorrono a rendere il processo di accoglienza complesso e tortuoso, e soprattutto non colpevole di sottrarre ai cittadini italiani i propri diritti e agi”.




